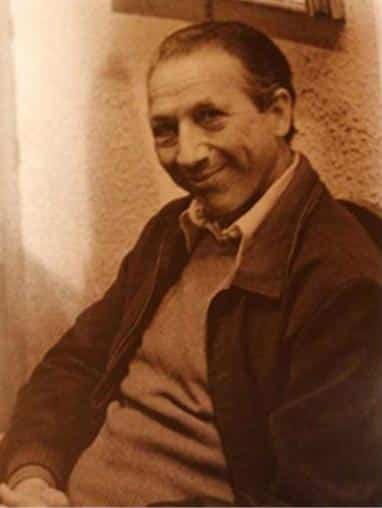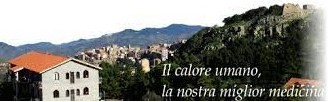“ L’officina delle parole” è il progetto che dall’a.s. 2023-24 l’Associazione Castelli-Di Pace promuove e conduce nel Liceo Tedaldi di Castelbuono con lo scopo di diffondere la conoscenza degli scritti di Antonio Castelli attraverso esperienze di lettura e ri-scrittura creativa. Nella scorsa primavera, il 29 maggio 2025, si è svolta la manifestazione conclusiva dell’esperienza svolta con le ragazze e i ragazzi della classe IVC coordinata dalla prof.ssa Lina Mazzola. Una prova di lettura in pubblico del testo “Parabbula da Simana Santa” sul quale la classe aveva lavorato lo scorso anno con attività di lettura, scomposizione, riscrittura con varianti, costruzione di repertori lessicali e dei “ditti”. Regista della prova Agostino Polisi che l’ha così presentata.
Buongiorno a tutti da parte della 4°C.
Oggi vi abbiamo riuniti qui per rendervi testimoni di un lavoro collettivo che stiamo portando avanti dall’inizio dell’anno, un lavoro che ci ha permesso di entrare in contatto con le nostre radici e in particolare con uno scrittore che è vissuto proprio qui a Castelbuono: Antonio Castelli.
Ci è stato quindi proposto un estratto proveniente dall’opera “Parti del discorso contadino”; l’anno scorso ci siamo dedicati ad analizzare questo testo e comprendere il suo significato, quest’anno invece ci siamo impegnati nel curare una piccola performance usando il testo come copione, i miei compagni recitando e io nei panni del regista.
Ognuno di noi ha poi scritto alcune frasi per esprimere l’effetto che ha avuto su di lui l’esperienza, e adesso ve le leggo:
“mi è piaciuto vivere la poesia in modo più creativo e coinvolgente”;
“ho conosciuto meglio il mondo contadino, i dialoghi e le discussioni. Ho imparato a recitare e a giocare con la voce”;
“mi ha ricordato mio nonno quando andava in campagna”;
“mi ha permesso di avvicinarmi ad un contesto di tradizioni popolari molto distante dal mio”;
“è stata un occasione per mettere a confronto la Sicilia di oggi e quella di ieri”;
“mi ha fatto pensare a come i miei nonni parlano ogni volta che li vado a trovare”;
“è stato affascinante recitare le parti di uomini vissuti prima di me ma con una simile cultura”;
“mi ha fatto capire che il mondo cambia e spesso lascia molti indietro”;
“mi ha ricordato un film di Ficarra e Picone, esperienza molto interessante”;
“mi ha ricordato un detto antico che mi diceva spesso mio nonno quando ero con lui in campagna”;
“mi ha lasciato un forte senso di meraviglia e gratitudine verso le generazioni passate”;
“recitare le parole di un autore siciliano mi ha fatto sentire parte del mio territorio”;
“è stato bello conoscere la storia dei paesi limitrofi”;
“mi ha trasportato ai vecchi tempi”;
“esperienza molto stimolante”;
“mi è piaciuto molto recitare con i miei compagni”;
“un lavoro molto diverso dalle solite cose che si fanno a scuola, l’ho veramente apprezzato”;
“ci ha permesso di riscoprire la lingua e le tradizioni siciliane”.
Questo progetto non sarebbe stato possibile senza l’aiuto dei due professori che ci hanno guidati dall’inizio alla fine, la professoressa Mazzola e il professore Castiglia, al quale vorrei adesso passare la parola.
Un momento della prova di “Parabbula da Simana Santa”
Il prof. Domenico Castiglia, presidente dell’Associazione Castelli Di Pace, interviene ringraziando il dirigente scolastico prof. Alberto Celestri, il prof. Giuseppe Peri, il Collegio dei docenti e il Consiglio d’Istituto per la sensibilità e disponibilità mostrate accogliendo il progetto nel Piano triennale dell’offerta formativa dell’Istituto. Con le ragazze e i ragazzi della IVC e l’indispensabile contributo della prof.ssa Mazzola è stato continuato il progetto sulla cultura contadina attraverso gli scritti di Antonio Castelli.
Rivolgendosi al pubblico chiede di alzare la mano chi abbia letto “Gli ombelichi tenui”, “Entromondo” o “Passi a piedi passi a memoria”. Nessuna mano si alza. Allora, brevemente, chi era il nostro autore? Nasce il 14 settembre 1923 a Castelbuono, in contrada Sant’Ippolito. Nel 1962 pubblica con la casa editrice Lerici, Gli ombelichi tenui e nel 1967 con Vallecchi, Entromondo. Nel 1985Sellerio pubblica un florilegio delle prime due opere, con il titolo Passi a piedi passi a memoria. Nel 1998 viene ripubblicato da Arnaldo Lombardi Editore il testo de “Gli ombelichi tenui “ proponendo per la prima volta “Parti del discorso contadino”. Nel 2008 la casa editrice Salvatore Sciascia pubblica l’opera omnia di Antonio Castelli a cura di Giuseppe Saja, Opere. E’ un invito a leggere un autore ancora molto attuale, ecco qualche breve lettura di presentazione del lavoro svolto. Castelli è scrittore di due mondi, uno quello della cultura contadina della quale teme il tramonto, l’altro quello della modernità, del progresso, quasi ineluttabile, che avanza, affascina e può travolge. Castelli esprime il dolore di questa lacerante contraddizione in Entromondo : “ Protestare bisogna contro il contagio modernista dei contadini. Si vuole che essi s’affranchino da certe insufficienze e limitazioni della loro classe, sentano e si adeguino al flusso del tempo nuovo?
Ebbene, sì, al “progresso”; ma che scorra lungo le radici contadine, che non le sommerga, non le insterilisca e annienti.”Dobbiamo chiederci: cos’è la cultura contadina? Quali sono le sue radici? Che rapporto ha il contadino con la terra?
Per Castelli è un rapporto di simbiosi, di tenero amore: “Prendergli l’anima al contadino è facile come prendere un uccellino al suo nido. In una mano l’uccellino può starci tutto, agevolmente, le sue ali, il suo volo, quella meraviglia nella nostra mano.
Il segreto è nella tenerezza della presa, nell’attenzione trepida con cui sappiamo custodirlo” (Opere, 2008, p. 109).
L’autore vuole conservare, salvare questa tenerezza, prima della sua estinzione, nell’uso della parola; mancando il discorso contadino, manca la sua cultura. Ed ecco l’urgenza di registrare la testimonianza del suo amico Beppe, i suoi racconti, le annotazioni sui “detti” antichi; un testimone di frontiera, prima del trapasso, del possibile oblio. Ecco come declina la tenerezza:
“ L’uso, nel discorso contadino, specie quando riguarda la terra e i frutti della terra, quel che dalla terra viene e alla terra rimanda, della parola in codeste forme bipartite, la propria e la diminutiva, la propria e la vezzeggiativa, alternate e variate, è quasi normale e costante.”
- ‘A racina; a racinedda; ‘u vinu; ‘u vinuzzu; l’alivi; l’alivuzzi; l’ogghiu; l’ogghiceddu.”
E vuole salvare anche le “parti del discorso” che le vittime del “disboscamento delle braccia”, i deportati della terra, portano con sé in Germania, in Francia, in Svizzera, nell’altrove. Frammenti che Castelli raccoglie nella seconda parte di Entromondo, per “Leggere nel cuore del contadino.”
E’ questo lo scrittore del primo mondo, ma lo è anche del secondo, del “progresso”. Scrive, sempre in Entromondo, nel 1967, una pagina profetica; dieci anni prima che fosse lanciato sul mercato il Wordstar, il primo programma di video scrittura; il Commodore 64 arriverà alcuni anni dopo.
“Presto tutti gli abitanti della terra, validi, saranno messi in condizione di conoscere i loro volti, l’uno dell’altro.
I volti passeranno, passeranno soltanto, dinanzi ai nostri occhi, perché essi possano ritenerli, «raccoglierli».
Così, tutti ci saremo visti, conosciuti. (Nessuno potrà dire più di non aver veduto un negro, affermare al cospetto di un negro «Non ti conosco»; e, di un americano, o di un russo «Se sapevo che eri tu » …).
Avremo in dotazione un salvadanaio personale di volti; e dovremo liberamente comporre una nostra immagine di uomo, non prescindendo tenendo bensì conto della gamma tipologica raccolta.
Un Revisore, periodicamente, senza preavviso, chiederà conto a ciascuno di noi del proprio fondo individuale; dell’uso fatto dei volti, dello stato in cui li conserviamo, del numero, di eventuali perdite, o di innaturali tensioni, contratture.
E un premio ci sarà dato, ricco, più ricco, in misura del’intensità dei volti che avremo saputo restituire, e della maggiore o minore qualità umana delle loro espressioni.
Le violazioni pubbliche, sociali, di lesa umanità, i peccati contro lo spirito del cosmo saranno giudicati in rapporto a quel che i nostri occhi «salvadanaio» hanno dentro di volti umani; e che essi siano naturali, schietti, non sbiaditi o indistinti”. (cit. “Opere, p.131). Una narrazione attualissima; i discorsi su FB e sull’AI sono del nostro secolo.
Ma ritorniamo al mondo contadino, alla Parabbula da Simana Santa, testo contenuto in Parti del discorso contadino, trascrizione di sei racconti del parlante Beppe, parte di una ricerca trasmessa dalla RAI, la cui “aspirazione” è quella di “ricostituirsi come narrativa orale”. Le attività svolte in questi due anni sono state un progressivo e naturale entrare nel testopiuttosto che cercare di farlo proprio, una ricerca del logos del racconto, della sua struttura fonica, la sua architettura, che porta le ragazze e i ragazzi ad una particolare partitura che oggi vi presentano a voce. Buon ascolto.
Agostino Polisi invita la prof.ssa Lina Mazzola ad intervenire.
“Benvenuti a questo incontro.
Accostarsi agli scritti di Antonio Castelli per i ragazzi della IV C del Liceo “Luigi Failla Tedaldi” di Castelbuono non è stata la mera scoperta dell’opera di uno scrittore raffinato, sensibile, connesso al mondo intellettuale nazionale attraverso una fitta rete di relazioni e collaborazioni, non solo letterarie. Affrontare poche pagine di Parti del discorso contadino, e dell’opera Entromondo, ha permesso ai ragazzi di fare un’esperienza emozionale ed emozionante: pervenire all’assunzione del “logos contadino”, fatto di “intelletto, discorso, parola”, del punto di vista ( e di vita!) dell’uomo che lavora la terra e vive, profondamente e in ogni sua fibra, l’inscindibilità del legame tra questa e il cielo, scandito dal ritmo delle stagioni e sacralizzato nella sequenza delle festività religiose. Una dimensione completamente altra rispetto all’universo dell’homo oeconomicus, di colui che pretende tutto e subito, rapace, avido, dissennato, e non riconosce altra autorità al di fuori del suo desiderio di possesso.
Del “discorso contadino” Castelli vuole cogliere “l’immaginosa plasticità, la sapidezza nella parlata di Castelbuono” e, seguendo la sua sensibilità musicale e un’intuizione profetica, decide di conservare su un nastro magnetico le chiacchierate fatte con il suo amico Peppe, mezzadro nel podere di Sant’Ippolito, 78 anni, che, come una vecchia vite, presenta “la peronospera dell’età” ma conserva “ancora verdissimo … il tralcio del linguaggio”. Ne trae sei brani, documenti di una lingua autentica, ancora incontaminata dalla lingua nazionale che in quei primi anni ‘60 arrivava in tutte le case diffusa dalla televisione, ma soprattutto la testimonianza di una visione del mondo che “spazialmente contiene tutto, la natura e la sovranatura, l’umano corporale e la sacralità dell’umano”.
Le pagine scelte sono state quelle della Parabbula da Simana Santa, una narrazione che si è prestata a diventare corale, fatta di un’alternanza di affermazioni e domande, stupore e disincanto, fiducia e disillusione. Ne è venuta fuori una rappresentazione vivace e intensa, che parte dalla considerazione delle annate che “vienunu tinti” per continuare con la riflessione su un mondo e che non sacralizza più il tempo, fino all’affermazione che “Dio è morto”: “Diu l’ammazzaru, l’ammazzaru …”, anche se la fiducia in una Pasqua in cui “sunaru i campani” è ancora forte. La narrazione si chiude con un ulteriore racconto che riprende l’alternanza di fiducia e disillusione: è la storia di un pastore che scolpisce un crocifisso dal legno di un pero selvatico che non faceva frutti, ma il crocifisso è sordo ad ogni preghiera e “unni fa miraculi!”
Le ragazze e i ragazzi (Alessia Solaro, Aurora Gesani, Chiara Brocato, Jennifer Brocato, Giuseppe Cimino,Gioacchino Cipriano, Giuseppe Barca, Umberto Sgrò, Gabriele Vacca, Maria Di Noto, Flavio Di Fatta, Nicolò Scancarello, Vincenzo Mazzola e Angelo Fulco) diretti da Agostino Polisi, con il supporto tecnico di Davide Lupo, hanno “vissuto”, più che interpetato, il testo, in uno scambio di voci e di sentimenti che hanno restituito il senso profondo della creaturalità di fronte alla natura e alla sovranatura.
La brevità nella semplicità della performance non deve trarre in inganno: si tratta del risultato di un percorso di progressiva scoperta di una lingua, la parlata castelbuonese, nota ai più ma non certamente conosciuta e vissuta. Attraverso la magia di un suono familiare e antico i ragazzi sono giunti, ognuno a modo proprio, alla scoperta di un mondo contadino in cui ciascuno ha potuto ritrovare tracce della memoria e del lessico familiare e ricomporre quel “midollo universale” in cui riconoscersi tutti.”
Agostino Polisi: “Ed ecco la IVC con la lettura di A fabbula da Simana Santa.
(testo)
Ora l’annati vienunu tinti,
e picchì vienunu tinti st’annati?
Vienunu tinti picchì
‘u Signuri ‘un esisti cchiù;
picchì prima c’era ‘u Signuri
e caminava pi lu munni
e unni vidieva cosi binidicieva.
Vidieva ‘u lavuri e binidicieva,
vidieva ‘u furmientu e binidicieva,
vidieva l’alivi e binidicieva,
a tutti banni binidicieva.
I parrini dunanu ‘u malisempiu,
picchì, picchì iddi propri
levanu tutti i belli festi
e fannu ‘u so piaciri,
chiddu chi vonni fari fannu;
ora, poi, chi vulemu a bonannata?
Nun ci ‘nne’ bonannata,
picchì i bonannati vienunu
ca ‘u Signuri binidicieva tutti cosi.
Diu l’ammazzaru, e l’ammazzaru …
Poi c’è ‘a parabbula
chi dicinu da Simana Santa.
A Simana Santa, ‘u Signuri scappau,
scappau e si nni jiu ‘nna inestra,
‘a inestra facia battaria,
si scantava ca cci ittavanu luci
e si nni jiu ‘nna parma;
da parma ficiru ‘a duminica da Parma,
poi ficiru ‘u Iovi Santu,
ficiru ‘u Venniri Santu, puru,
‘a Madonna jieva ‘a circari ‘u figghiu
e dicea: me figghiu unn è?
L’ammazzaru! e picchì l’ammazzaru?
Ca, dicinu, havianu a fari
a simana ca Diu ‘un esisti cchiù
e ficiru ‘a parabula da Simana Santa.
Poi vinnu ‘u Sabbatu Santu,
poi sunaru i campani
e arrivisciu arria ‘u Signuri
e ficiru Pasqua.
Finiu finiu.
Poi c’era un picuraru ca sa pinsau;
havia un bellu stabiliddu;
si nni jiu ‘nno stabiliddu,
c’era un bellu pedi di piraniu minchiunutu,
ora, dici, di stu pedi di piraniu
chi nnaiu a fari ca ‘un fa nenti,
ora ‘u ‘nzitu a piru,
e ‘u ‘nzitau a piru.
Piru ‘nno tempu da so vita stetti,
pi la Madonna,
e pira unni facia mai.
Ora, dici,
‘u tagghiu e fazzu un crucifissu
e fici un bellu crucifissu magnificu.
I picurari sunni adatti a fari sti cosi.
Fici ddu beddu crucifissu
e miraculi unni facia ddu crucifissu.
Nni putia fari miraculi mai,
ca era di piru?
E poi ci ficiru ‘a poesia.
Piru nascisti di morti eccellenti,
‘nno tempu da to vita
pira unni facisti,
ora ca sini crucifissu di prisenza,
pira ‘un facisti e miraculi voi fari!
Unni fa miraculi!
E finiu ‘u munni, si distruggia.
(Antonio Castelli, Parti del discorso contadino,
in Opere, Salvatore Sciascia Editore, 2008, pp.233-234)
A cura dell’Associazione Castelli Di Pace, Castelbuono.